Dialoghi – Inglese o mandarino? Nel Sud-Est asiatico molti scelgono il cinese
Aprile 2025
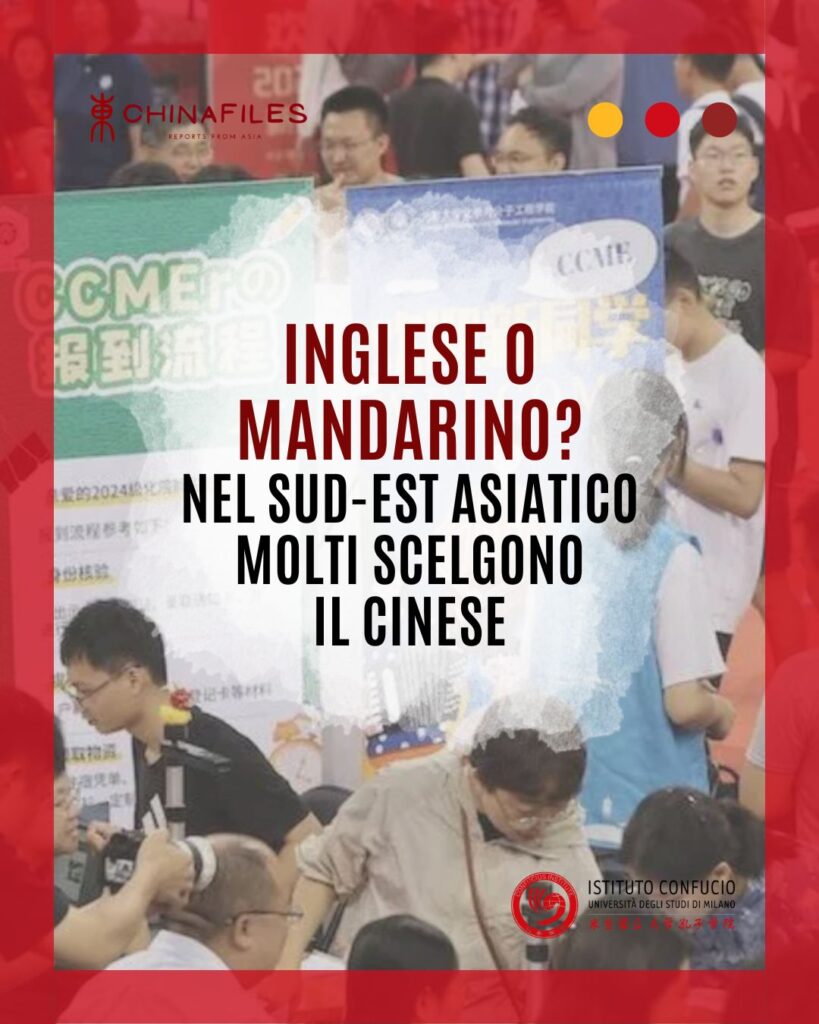
Da tempo, nel Sud-Est asiatico, studiare il mandarino è diventata una scelta sempre meno di nicchia. Nonostante l’inglese resti ancora molto forte come seconda lingua, il potenziale isolamento commerciale degli Stati Uniti potrebbe accelerare il processo di promozione del cinese nella regione, già avviato da decenni per ragioni economiche e culturali. “Dialoghi: Confucio e China Files” è una rubrica in collaborazione tra China Files e l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano.
di Francesco Mattogno
Del recente viaggio del presidente cinese Xi Jinping nel Sud-Est asiatico (dōngnányà, 东南亚) si è parlato molto, soprattutto in termini commerciali. Tra il 14 e il 18 aprile Xi ha fatto tappa in Vietnam (yuènán, 越南), Malaysia (mǎláixīyà, 马来西亚) e Cambogia (jiǎnpǔzhài, 柬埔寨), tre dei paesi maggiormente colpiti dai dazi imposti a inizio aprile dagli Stati Uniti, poi sospesi per 90 giorni a seguito del crollo delle borse americane. Il contesto ha aiutato Xi a presentare la Cina come garante del libero commercio in contrapposizione a un attore, Washington, che molti degli storici partner regionali degli Stati Uniti potrebbero cominciare a ritenere inaffidabile.
Per questo, durante il suo tour nella regione, Xi ha firmato con i leader dei tre paesi decine di accordi di cooperazione per rafforzare gli investimenti cinesi in vari settori, dalle nuove tecnologie alle infrastrutture. Ma non si è discusso solo di economia e commercio. Tra le altre cose, le parti si sono impegnate a potenziare gli scambi culturali e la collaborazione nel settore dell’istruzione, che rappresenta da tempo uno degli ambiti in cui la Cina (e il cinese) ha fatto grandi passi in avanti in termini di appeal per gli studenti regionali, anche a discapito dell’inglese.
Opportunità lavorative (e non solo)
Dal 2020 l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) è il primo partner commerciale della Repubblica popolare, che è a sua volta il paese con cui l’ASEAN (dōngnányà guójiā liánméng, 东南亚国家联盟) commercia di più in assoluto, già a partire dal 2009. Nella regione la Cina costruisce, investe ed “esporta” milioni di turisti ogni anno, il che rende l’equazione abbastanza semplice: per uno studente sud-est asiatico, studiare il mandarino significa quasi sempre avere un posto di lavoro assicurato dopo il diploma o la laurea.
Secondo un report di Fulcrum, che ha analizzato i principali portali di ricerca e offerta di lavoro in Malaysia, in oltre il 20% delle offerte di lavoro presenti si richiede una buona conoscenza del cinese, condizione che in diversi casi è preferenziale rispetto alla capacità di parlare inglese. Se è vero che circa il 20% della popolazione malaysiana è di etnia cinese, negli ultimi trent’anni il numero di studenti non di etnia han che si sono iscritti in una scuola cinese, in Malaysia, è aumentato del 484% (erano 101 mila nel 2020 contro i 17 mila del 1989).
La stessa tendenza è evidente anche negli altri stati regionali. Per VietnamWorks (una sorta di Linkedin vietnamita) chi parla mandarino ha praticamente il 100% di possibilità di trovare lavoro in Vietnam, mentre a Sihanoukville, la “città del vizio” cambogiana dove «le aziende cinesi sono ovunque», saper comunicare in mandarino è un requisito fondamentale per lavorare in qualunque settore, dai casinò agli hotel, passando per ristoranti e fabbriche.
Ma c’è qualcosa di più oltre alle opportunità lavorative. In Laos ci sono scuole in lingua cinese che offrono percorsi di istruzione che vanno dall’asilo alla scuola superiore, insieme a vari corsi per funzionari e diplomatici, frequentati anche dai politici del paese. In Brunei, dove la comunità cinese rappresenta poco meno del 10% della popolazione, le scuole che offrono corsi in cinese sono in forte ascesa perché hanno la reputazione di essere i migliori istituti nazionali, dove si formano gli studenti più preparati del paese.
Oltre a questo rigore accademico, a molte famiglie le scuole cinesi piacciono anche per l’ambiente multiculturale che riescono a offrire. Si tratta di un fattore non banale in una regione multietnica in cui resistono però forti nazionalismi e movimenti identitari di matrice etnico-religiosa, e dove la convivenza con le minoranze cinesi è stata a lungo parecchio complicata (ne avevamo parlato anche in questa puntata dedicata all’insegnamento del mandarino in Indonesia).
Critiche, diffidenza, storia
Negli anni sono stati quindi annunciati piani e programmi di vario genere, dalle borse di studio ASEAN-Cina per la formazione dei futuri leader regionali, al lancio di vari istituti professionali di artigianato moderno nella regione, promessi da Pechino. La Cina ha iniziato a spingere sull’acceleratore soprattutto a partire dall’inizio degli anni 2000, iniziando a promuovere, sotto l’egida del ministero dell’Istruzione, varie iniziative educative e di insegnamento del mandarino in giro per la regione (e per il mondo).
Per i critici, esportare la lingua cinese è una delle armi di soft power di Pechino, che da tempo pone grande enfasi sulla questione – presentando spesso l’importanza degli “scambi people-to-people” – per migliorare la sua immagine all’estero. Varie amministrazioni americane hanno denunciato le presunte operazioni di influenza di queste istituzioni cinesi all’estero, mentre partiti e organizzazioni religiose in paesi a maggioranza musulmana, come Malaysia e Indonesia, sostengono che la promozione della letteratura cinese (e delle sue implicazioni filosofico-religiose: confucianesimo e taoismo su tutte) possa ostacolare l’integrazione tra i diversi gruppi etnici.
Le scuole cinesi nel Sud-Est asiatico hanno però una storia che spesso esula da quella della Repubblica popolare, e che non ha a che fare solo con la politica. I primi istituti cinesi nella regione nacquero nella prima metà del Novecento per rispondere alle esigenze della corposa diaspora cinese, e ancora oggi servono innanzitutto come siti di conservazione culturale delle minoranze cinesi nei diversi stati ASEAN. La cooperazione educativa tra la Cina e i paesi della regione ha vissuto poi una serie di alti e bassi alla luce dei rapporti diplomatici tra Pechino e i singoli stati, ed è solo con la stabilizzazione degli ultimi vent’anni, dovuta principalmente alla maggiore integrazione economica e commerciale, che le cose si sono strutturate e l’insegnamento del mandarino ha cominciato a diffondersi in modo capillare nell’area.
Al momento si può dire che esistono tre tipologie di “scuole cinesi” nel Sud-Est asiatico: gli Istituti Confucio (che sono una quarantina), le filiali estere di varie università cinesi e le vere e proprie scuole cinesi, che offrono corsi di cinese o di altre materie, ma in mandarino. Le opportunità economiche non riguardano solo gli studenti, tra l’altro: nel contesto di grave calo demografico per la Cina, il bacino del Sud-Est asiatico rappresenta un’ottima fonte di finanziamento per le università cinesi, che nei prossimi anni subiranno un pesante calo di iscrizioni. Oggi quasi uno studente internazionale su tre, nella Repubblica popolare, viene dal Sud-Est asiatico.
L’effettiva influenza politica di questi istituti sulle nuove generazioni di sud-est asiatici potrebbe dunque dover essere ridimensionata alla luce del pragmatismo economico e degli scambi interculturali, che sembrano essere il vero motivo per cui tante persone iniziano a imparare il mandarino. L’avanzamento tecnologico e scientifico di Pechino, così come l’alto livello delle istituzioni scolastiche cinesi, rende poi sempre più appetibile la prospettiva di andare a studiare in Cina e quindi scegliere il cinese come seconda lingua.
Va inoltre considerato che alcuni degli stati ASEAN (storicamente “non-allineati”) hanno delle controversie territoriali aperte con la Cina, nel mar Cinese meridionale, e avrebbero tutte le ragioni per evitare “l’indottrinamento” dei propri giovani a favore delle istanze di Pechino, vietando questi istituti. Il vero assist politico e di soft power alla Cina potrebbe allora essere arrivato da Trump: se gli Stati Uniti si isolano, l’inglese in Asia perde appeal e sempre più giovani potrebbero scegliere di puntare sul cinese per garantirsi un futuro. In parte è così già da tempo, i dazi americani potrebbero solo aver accelerato il processo.